

Michel Houellebecq, La possibilità di un’isola
Bompiani editore, 2005, € 18,00, ISBN 88-452-3493-2
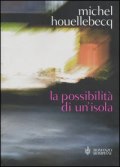
L’ultimo romanzo di Houellebecq rappresenta, sotto molti aspetti, un inquietante sviluppo della sua precedente riflessione narrativa sul tema della clonazione, Le particelle elementari (da cui di recente Oskar Roehler ha tratto un film). Ne La possibilità di un’isola, molto più che ne Le particelle, la struttura diegetica tradizionale – il cinico ma patetico racconto di vita dell’umano Daniel, disperatamente attaccato al sesso proprio come il Bruno Clément de Le particelle – pur occupando molte (troppe) pagine funge da mero sfondo: si tratta di un materiale brulicante, pensato forse per i lettori di bocca buona o per i fanatici della New Age, ma sistematicamente inframmezzato dagli algidi commenti elaborati da due cloni ‘neoumani’ dello stesso Daniel – commenti nei quali Houellebecq appena dissimula un vero e proprio trattato sulla possibilità di clonare l’uomo. Non siamo di fronte ad una semplice contro-utopia, o ad una distopia sulla falsariga del Mondo nuovo di Huxley, quanto piuttosto ad un attacco in grande stile sferrato su due fronti: contro l’umanesimo moderno, ma anche contro i postmoderni disinvoltamente post-umani. In alcuni vertiginosi passi contenuti nelle meditazioni di Daniel 24 e Daniel 25, e talvolta nelle stesse lamentazioni ‘umane’ del loro prototipo genetico, Daniel 1, Houellebecq conferma la sua antica propensione saggistica (meno redditizia, è chiaro, di quella letteraria), facendo i conti con una certa parte del pensiero contemporaneo; questa sua pretesa speculativa può forse renderlo antipatico agli accademici patentati, ma invoglia ad aggirare i morbosi, quanto volgari paludamenti narrativi di cui si ammanta, per scendere apertamente sul terreno concettuale – cedendo, insomma, alla tentazione di fare una recensione filosofica, il che è probabilmente proprio quello che Houellebecq vorrebbe.
Nella conclusione de Le particelle elementari, Houellebecq immaginava una clonazione che avrebbe soppresso il ‘male’ dell’individualità realizzando una massa di individui con il medesimo codice genetico, ed abolito le differenze sessuali a favore di un unico sesso, quello femminile. Ne La possibilità di un’isola, pur conservando l’idea di un’egemonia futura del sesso femminile – adombrata dagli insegnamenti iper-buddhisti e ‘spinoziani’ della Sorella Suprema, su cui meditano i cloni di Daniel – lo scrittore ha preferito elaborare una sorta di de-sessualizzazione dei neoumani, ottenuta, oltre che in virtù di una modificazione genetica, grazie all’isolamento e dunque al superamento della socialità. Se la società è Dio (Durkheim), nel futuro di Houellebecq Dio è morto.
In entrambi i romanzi, questo luttuoso scenario appare preparato da tre elementi che sembrano essere già all’opera nel postmoderno, e che Houellebecq s’incarica semplicemente di portare alle estreme conseguenze: la desuetudine, o meglio la malinconica superfluità, del pensiero filosofico moderno (da Hegel a Deleuze, per intenderci) concepito come potenza critica dello spirito in grado di capire, se non di cambiare, il mondo; la diffusione delle sette new age (si pensi a Scientology o ai raeliani), in cui l’ingenuità delle teorie pseudo-scientifiche sconfina nell’idiozia degli adepti, portando a veri e propri deliri di massa, ben poco dissimili da quelli fomentati dalle religioni monoteistiche; la corporeizzazione ossessiva e consumistica dell’esperienza (soprattutto di quella sessuale), che finisce col rendere, appunto, superflua l’intelligenza individuata e col sacrificare la ricerca scientifica al nuovo Moloch dell’eternità corporea.
Non si tratta di un’eroica lotta contro lo scandalo insopportabile della morte, né di un rifiuto etico della sofferenza concepita come atroce perdita di dignità – perché, se così fosse, la clonazione sarebbe una specie di risarcimento morale pagato dalla scienza, ed Houellebecq si troverebbe ancora immerso nell’orizzonte umanistico, che invece disprezza. La frase con cui egli apre il romanzo – chi, fra voi, merita la vita eterna? – rappresenta piuttosto una condensazione negativa delle succitate tendenze operanti nel mondo contemporaneo: se “l’‘io’ è la sintesi dei nostri fallimenti” (p.15), nessuna singola vita ha valore, nessun io particolare merita l’eternità – e tuttavia per alcuni ‘io’ qualunque (nella fattispecie romanzesca per l’apatico Daniel, che non prova dolore nemmeno per il suicidio del figlio, cfr. p.26) essa è disponibile come il più seducente dei beni di consumo. La clonazione diventa una possibilità reale, ed un privilegio sociale, proprio quando l’umanità appare ormai spaventosamente mediocre, incapace di godere la vita se non grazie ad orgasmi multipli – inseguiti da Daniel nella frenesia di una gioventù tanto vorace quanto ebete (incarnata alla perfezione dalla ‘lolita’ Esther).
Il futuro della clonazione è dunque, per Houellebecq, il nostro presente. Ciò che egli descrive, non è altro che lo squadernamento leibniziano della nostra realtà. Quando e perchè l’umanità, svuotata di ogni senso e chiusa in un tetro egoismo, è giunta al punto da concepire la possibilità (se non la necessità) di estinguersi bloccando la riproduzione sessuata, abolendo sia l’infanzia che la vecchiaia come ingombranti cause di altruismo sociale, la clonazione permette di fabbricare all’infinito singole individualità adulte, che, grazie all’isolamento ozioso ed all’autotrofia, diventano asettiche ed anaffettive: “Le gioie dell’essere umano ci restano insondabili; i suoi dolori, invece, non possono distruggerci; le nostre notti non vibrano più di terrore né di estasi” (p.11). Questa incapacità di provare emozioni (“ogni emozione è kitsch”, p.123), di assegnarsi dei compiti o degli scopi, di legarsi ad un altro essere vivente (che non sia il cane Fox, la cui ottusa istintività appare comodamente eternizzata al servizio dell’umana senilità), caratterizza i neoumani nella misura in cui costituisce la più pesante eredità di quegli umani che ne hanno fornito il prototipo.
La meschina vita di Daniel, che è la nostra vita di occidentali annoiati e obnubilati dal benessere, viene riletta dai suoi cloni a distanza di millenni, dopo una glaciazione ed un “prosciugamento” che hanno quasi spazzato via dalla faccia della terra la ‘vecchia’ specie umana, i cui residui sono ridivenuti selvaggi. Da questi neoanimali i neoumani si proteggono con orrore misto a pietà, mentre la loro esistenza scorre “senza gioia e senza mistero” (p.11). Verso cosa? Verso un sogno posto ad arte al di là dell’ultima frontiera dell’utopia, cioè al di là della clonazione, che viene così declassata da eternità a stato transitorio: se i neoumani sono una specie intermedia e soltanto gestatoria, “questo libro è dedicato all’edificazione dei Futuri” (p.15), ovvero della nuova specie preconizzata dalla Sorella Suprema, che sarà finalmente in grado di superare l’umano inaugurando l’esistenza cosciente di un unico essere costituito da menti clonate, da reti neurali, da fredde entità digitali. Ma nell’entusiasmante digitalizzazione espansiva del neoumano, che dovrebbe preludere all’avvento del superuomo, qualcosa va storto. Un po’ come la voce del computer Hal 9000 nel capolavoro di Kubrick, i commenti di Daniel 24 e Daniel 15 cominciano a stridere, a negare ciò per cui sono stati programmati: la felicità.
La teoria della Sorella Suprema è nicciana e spinoziana insieme: “Ammettere che gli uomini non hanno né dignità né diritti; che il bene e il male sono nozioni semplici, forme appena teorizzate del piacere e del dolore. Trattare in tutto gli uomini come animali” (p.39), e gli animali – il cane Fox – come uomini. Si tratta di una “via nobile ed eccellente”, segnata proprio quando gli uomini “stanno abbandonando la partita” (ibidem) perché ormai, persino nell’amore istintivo degli animali per i loro padroni, vedono un mistero impenetrabile. I neoumani devono meditare sui banali racconti di vita dei loro antenati umani, fino a considerarli ripugnanti e noiosi – cioè inferiori. Inferiorizzare un’umanità già devastata dalla sua stessa evoluzione socio-culturale, rappresenta infatti il primo passo per abbandonare la limitata condizione individuale – per superare il ‘fallimento’ della soggettività. Ma questo obiettivo viene perseguito dai cloni grazie all’isolamento psico-fisico: una sorta di terapia omeopatica che tende a distruggere l’individuazione intensificandone i sintomi. Inoltre, i cloni continuano a fingere di morire: raggiunto il momento in cui verranno sostituiti dall’ordinale successivo, appaiono malinconicamente consapevoli di una dipartita che è solo un trasloco genetico. Perché? Perché la Sorella Suprema ha lasciato loro, a mo’ di aristocratica condanna, il lusso dell’antico uomo sociale: l’intelligenza. “L’intelligenza consente il dominio del mondo” (p.137), anche e soprattutto dopo che il brulicare umano si è ormai estinto, con tutto il suo fastidioso calore: “la sparizione della vita sociale” (p.138) è il vero obiettivo ascetico della clonazione; essa va sostituita da un’unica entità plurale intelligente, vuota, asessuata e perciò felice – i Futuri.
C’è una contraddizione tra l’eternità corporea e la felicità intellettuale, che minaccia di imballare i cloni, proprio come accade all’infallibile Hal 9000. Quando Daniel 25 prende il posto del suo predecessore nel commento alla squallida vita del prototipo, il lettore si trova ormai davanti alla scrittura di un depresso – ed è una depressione preparata da ben ventiquattro generazioni. Come Dio, Daniel 1 pensa se stesso da più di duemila anni: per l’eternità egli si racconta le disgustose vicende criminali (assolutamente kitsch, cfr. sprt. pp.238-247) che hanno portato alla sua immortalità; meditate all’infinito, esse non possono che produrre un’infinita nausea. Se nessuno ha valore – questa è in fondo l’implicita conclusione di Daniel 25, che si aggrappa con ferrea logica alla teoria della Sorella Suprema – tutti possono eternizzarsi; il che toglie ogni valore all’eternità – cioè a me, al clone numero 25. “Il nulla annienta”: a p.270, Houellebecq cita Heidegger per consacrare la nostra debolezza – la nostra nullità, che riesce persino a farsi passare per Dio.
Un plumbeo, dubbioso distacco domina le riflessioni di Daniel 25 sugli eventi che hanno portato il delirio degli elohimiti (alias hubbardiani, alias raeliani o quant’altro) ad una ridicola “vittoria sulla morte” (p.295). È come se egli, resosi ormai conto di essere il frutto di una stupida involuzione spacciatasi per progresso, fingesse, da solo, di attribuire senso alla teoria della Sorella Suprema, di credere alla “libertà dell’indifferenza, condizione di possibilità della serenità perfetta” (p.308). Clonare l’ipocrisia non è l’unico risultato psicologicamente degno di nota che l’uomo potrebbe ottenere lanciandosi in quest’avventura. Ma è sicuramente uno dei più assurdi, nella misura in cui si tratta di un’ipocrisia autoreferenziale: Daniel 25 finge di esercitare, davanti a se stesso, “un’attività mentale residua distaccata da ogni posta in gioco, orientata verso la conoscenza pura” (p.349). E questa conoscenza consiste nel sapere che “l’umanità non meritava di vivere” (p.365). Daniel, da 1 a 25, non può provare “la felicità dei bravi bambini” (p.361), perché, appunto, non la merita. Egli non è che un uomo copiato, sbiadito, macchinalmente vecchio: “come [gli uomini], eravamo soltanto macchine coscienti; ma, contrariamente a loro, eravamo consapevoli di essere soltanto macchine” (p.385).
Noi siamo già dei cloni a bassa intensità: siamo dei replicanti estenuati e inebetiti del soggetto occidentale moderno. Ma lo scrittore Houellebecq addolcisce questa lucida consapevolezza, che lo porta ad una definitiva liquidazione dell’umanesimo e del suo speculare nemico – il pensiero del superuomo – , con due trucchi narrativamente fruttuosi, anche se filosoficamente deboli.
Da un lato, come si è detto, il suo romanzo finge di rovesciare l’incubo della clonazione nell’attesa messianica di un nuovo essere plurale – una gigantesca identità metafisica (ma anche elettronica, quasi macluhaniana: cfr. p.186) ormai scevra di passioni, completamente purificata: i neoumani sognano, sperano come bambini viziati nell’avvento dei Futuri “esseri di silicio” (p.395). D’altra parte, gli stessi neoumani disertano come ragazzini: con le loro “defezioni”, essi abbandonano questo lentissimo progetto superomistico per rifugiarsi nell’isola dell’amore, cioè ritornano indietro; non verso la socialità estesa (direi politicamente costruita) della modernità, ma nel liquido amniotico dell’eros – vogliono sciogliersi nei sentimenti, nelle passioni, nell’assurda infelicità del desiderio e dell’individuazione. Daniel 25 abbandona la sua solitaria residenza dopo aver letto una poesia del suo antenato Daniel 1, che celebra (tanto per cambiare) “il tremito dell’essere, …l’amore in cui tutto è facile, in cui tutto è dato nell’attimo” (p.355).
Ma nell’assurda ricerca di un clone femmina (Marie 23), anch’esso disertore, Daniel 25 trova soltanto l’animalità degli umani sopravvissuti alla catastrofe e riscopre la vera, unica attesa dei viventi: quella della morte, che – dopo sessant’anni di placida solitudine – lo coglierà su una terra ritornata vergine e immensa. La morte di un’insensata eternità viene umanamente decisa dal clone di Daniel come una liberazione, una benedizione onirica; forse per questo Houellebecq non la descrive, ma, per così dire, l’accarezza: “La felicità non era un orizzonte possibile …il corpo mi apparteneva per un breve lasso di tempo; non avrei mai raggiunto l’obiettivo assegnato. Il futuro era vuoto… Ero, non ero più.” (pp.397-398).
(Eleonora de Conciliis)

